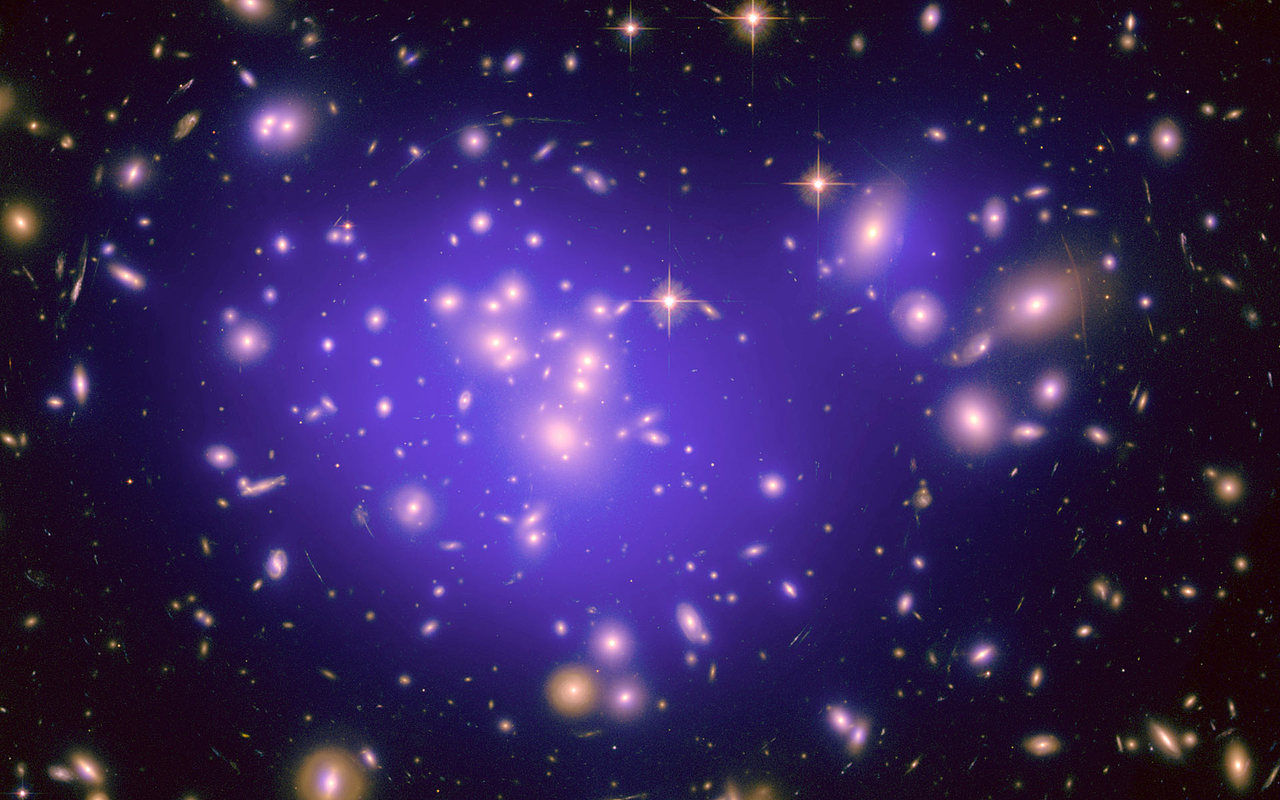
© Copyright 2023 Su CHIZONEDDU Web de Sardus.Filius.
FIZU DE S'APOCALISSE
S'Apocalisse de Santu Giuanne apaltened' a unu genere litterariu, s'apocalittica, chi s'est isviluppadu in mes' 'e sos ebreos a paltìre da III seculu a.C., a poi de s'esiliu babilonesu. Fu' sa manifestazione de su nazionalismu de unu populu chi fud' 'istadu dominadu da PERSIANOS primu, poi da sos TOLOMEOS e, in ultimu, da sos SELEUCIDES.
Gia' in sa fas' 'e s'esiliu su propheta EZECHIELE haiat annunziadu sa prummissa 'e Deus: « Goi narat Deus soberanu: Hap' a leare sos de Israele da sas zentes a inue sun' andados e los hap' a radunare da ogn' ala, e los hap' a torrar' a cunduer' a sa terra issoro: Hap' a fagher' de issos unu solu populu in sa terra mia, in sos montes de Israele; unu solu Re hat a regnare subra totu issos e no han' a esser' pius duos populos, ne pius han' a esser' divisos in duos Rennos .... e han' a esser' su populu meu e deo hap' a esser' su DEUS CUN ISSOS .... e hap' a fagher' cun issos un'alleantzia eterna ..... in mesu issoro hat a esser' sa domo mia: Deo hap' a esser' su Deus issoro e issos han' a esser' su populu meu » (Ez. 37, 20-27).
In quella profezia era descritto “il regno di Dio sulla terra”, le premesse per tutte le apocalissi successive e, da questo momento, nella cultura giudaica e in quelle che da essa derivano, si afferma l’idea che la storia abbia un fine (eskaton): La vittoria del bene sul male ed il regno di Dio sulla Terra. “Se le profezie non si sono ancora avverate”, scrive Romolo Gobbi nella sua “Storia di un mito dalle origini ai nostri giorni”, “se il “Regno di Dio” ritarda, ciò è dovuto all’esistenza di una forza antagonista, il principio del male, che esercita la sua azione negativa nella storia”.
Questo schema, che ebbe grande sviluppo, venne contrastata dai sacerdoti (la “casta” degli scribi e dei farisei ipocriti a cui si rivolge lo stesso Gesù Cristo accusandoli di legare “pesanti fardelli” e di imporli “sulle spalle della gente” – Mt. 23, 4 – trasgredendo “le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà” – Mt. 23, 23 – ) che giunsero fino alla distruzione dei testi originali ed al tentativo di far perdere la coscienza della “profezia” al popolo di coloro che credono. Ciò era dovuto certamente alla percezione da parte dei «maestri» dell’effetto sovversivo del mito apocalittico. In gioco non vi erano solo sottili questioni teologiche ma la concreta minaccia rappresentata per l'ordine costituito, ecclesiastico e secolare.
Se la visione dell'Apocalisse, oggi, è viziata da un fraintendimento di fondo, per cui essa è divenuta sinonimo di catastrofismo e di radicale pessimismo, non è certo per colpa della "cultura laica moderna", ma le ragioni vanno ricercate molto più lontano, nella profonda modificazione del suo originario significato conseguente ai mutamenti storici che portarono la Chiesa ad allearsi con l'impero, secolarizzandosi. Evento, questo, di portata epocale che condusse all'abbandono della fede nel prossimo ritorno di Gesù, di quella speranza escatologica, alimentata principalmente dal Libro della Rivelazione, che aveva aiutato a mantenere desta la fiducia nel futuro dei primi cristiani e a sostenerli nel martirio al tempo delle persecuzioni.
A questo punto può essere importante collocare storicamente il libro del profeta Giovanni: La letteratura apocalittica giudaica terminò dopo l’insurrezione ebrea contro Roma nel 70 d.C. che vide la sconfitta sanguinosa dei ribelli e la distruzione del tempio di Gerusalemme. Continuò a trascinarsi fino al 135 d.C. con la riconquista della Giudea da parte di Adriano, dopo di che scomparve totalmente come indirizzo letterario.
In seguito l’apocalittica e il messianismo apocalittico non spariscono dalla coscienza ebraica, tutt’altro, anche se la “saggezza rabbinica” fa del suo meglio, come sempre, per soffocare le tendenze rivoluzionarie. L’idea che prima della fine del mondo regneranno sulla terra i giusti infiammò le speranze di giustizia di più di un credente fin dai primi anni del cristianesimo, episodi che si sono ripetuti ancora fino alla fine dell’Ottocento e, dopo le due guerre mondiali, coi movimenti anticoloniali che scoppiarono in tutto il mondo”.
Oggi, con tutto quello che accade nel mondo, tornano alla mente sardonicamente le parole che i profeti riportano in Sofonia 3, 6-7: “Ho sterminato le nazioni, le loro torri d’angolo sono distrutte … Io pensavo: «Almeno ora mi temeranno! Accoglieranno la correzione … Ma invece si sono affrettati a pervertire di nuovo ogni loro azione»”.
Perché dunque meravigliarsi dell'ignoranza che ancora oggi circonda l'opera, se tra gli stessi esperti si avanzano forti dubbi sull'importanza degli scritti profetici? Tenuto conto della scarsa considerazione di cui gode l’Apocalisse, è comprensibile che alla fine sia prevalso, nella generale indifferenza, un concetto cosi distante dal suo originario significato. “Infatti, mentre il messaggio evangelico appare genericamente consolatorio e riformista, con l’Apocalisse di Giovanni torna il linguaggio del Vecchio Testamento grondante vendetta e sangue. Certamente non era intenzione del profeta quello di lanciare un messaggio di rivoluzione sociale, ma da quel momento ed in ogni tempo, gruppi di fedeli cominciarono a credere nel mito millenario.
Per capire la spiritualità dell’Apocalisse bisognerebbe affrontare il discorso della interpretazione, la quale condiziona la comprensione del messaggio spirituale del libro. Senza dubbio la sua scarsa conoscenza, specie in ambito cattolico, tradizionalmente poco avvezzo ai testi sacri, ha condizionato non poco a lettura dei segni descritti nel libro; la scarsa familiarità con lo scritto profetico attribuito a Giovanni ha avuto un peso decisivo come pure, alla sua comprensione, non hanno giovato né la ridotta utilizzazione nella liturgia romana né le questioni esegetiche, originate dal linguaggio oscuro tipico degli oracoli, e la serie di interpretazioni che ne sono derivate risultano spesso in contrasto tra loro.
All'origine dell'uso improprio dell'Apocalisse sarebbe dunque la natura stessa, ambigua e sfuggente, dell'opera profetica, sulla quale si sono esercitati gli ingegni dei Padri della Chiesa e d'interpreti di varia estrazione dottrinale, cattolica ed evangelica, senza giungere peraltro ad un modello universalmente accettato di lettura. Oggi, grazie a una serie incredibile di nuove scoperte ed intuizioni, l’Apocalisse di Giovanni inizia a riacquistare un chiaro senso escatologico.
La letteratura apocalittica è nettamente delimitata nel tempo: accompagna la comparsa della presenza seleucide in Palestina, e trova la sua prima espressione nel libro di Daniele (verso il 163 a.C.); si prolunga poi fino all’indomani della seconda insurrezione degli ebrei in Palestina (135 d.C.).

Su CHIZONEDDU Web

